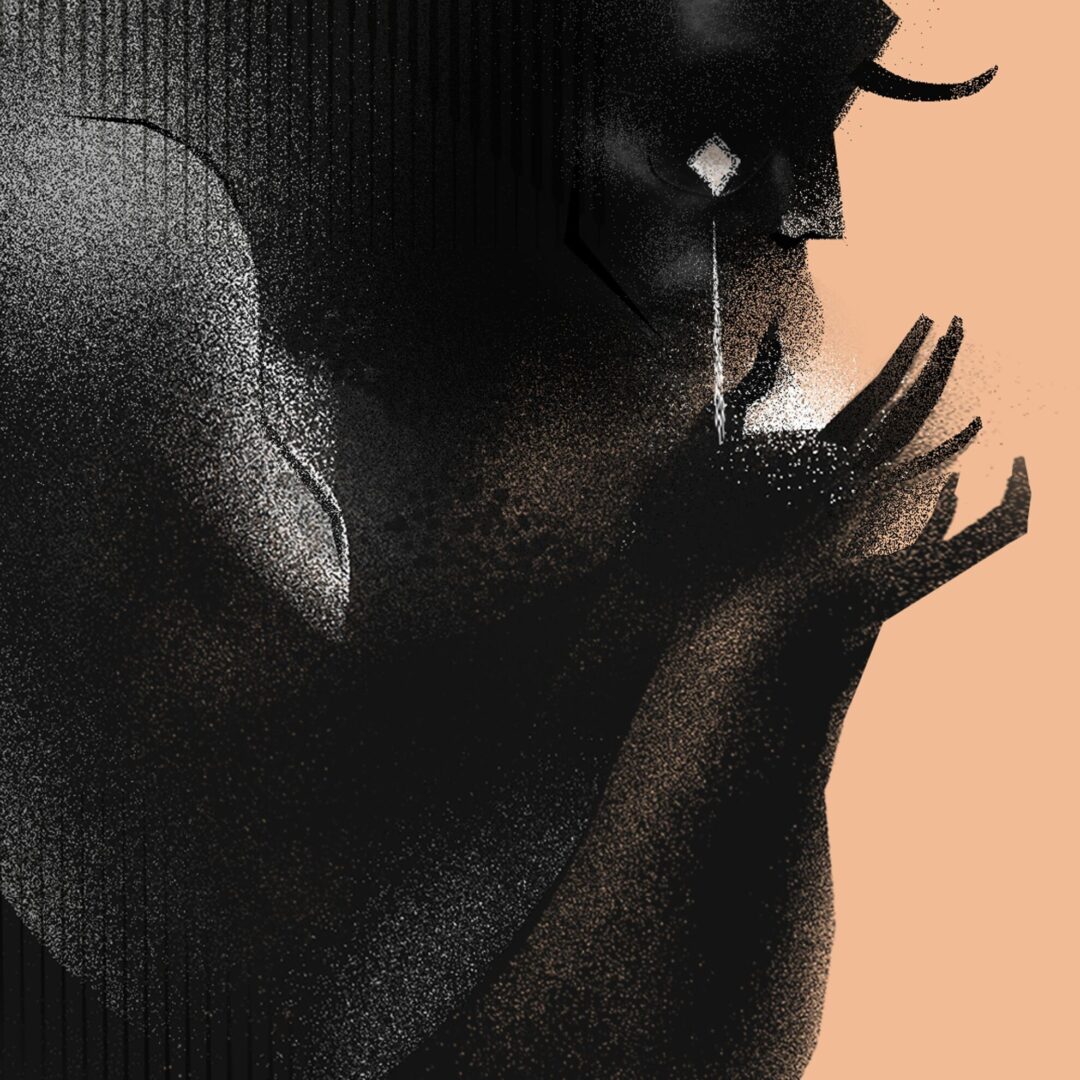Era mia, cioè:
non era altrui.
Eppure voleva esserlo?
aveva una sua volontà, che non era la mia?
Era tesa e dura, poi morbida, enorme fino al minuscolo. Viveva di una vita sua, vibrava.
Era me? era in me? era con me?
Era mia, ma le ero insufficiente. La sua forza non si esauriva in me: si protendeva.
In questo protendersi, era tormentata dal tormento: il terrore di darsi, il desiderio completo – incessante – di darsi.
La curavo, me ne prendevo cura. La rassicuravo, la assicuravo. Ero la sua tana e la sua prigione.
Fino a che era mia, e mia solamente, sapeva che non le sarebbe accaduto niente.
Di spiacevole, di imprevisto.
Sapevo – ho sempre saputo – che non si concludeva in me.
Era fatta per, sembrava nata per raggiungere; aspirava.
Così mi facevo ampio, slabbravo ogni bordatura, la ingannavo. La distraevo, la manipolavo – nenie lente e pesanti, suoni ipnotici perché si addormentasse, perché avesse pazienza.
Aspetta, aspetta ancora, amore mio. Le dicevo, cioè dicevo a me. Quando sarà il momento di darsi non ci sarà terrore. Sarà una discesa lieve, vedrai. Lo sentirai.
Erano parole.
Non riuscivo a distinguere il rancore dall’irrequietezza. Non riusciva più a essere solo mia, non perché desiderasse essere libera. Sapevo che la libertà non l’aveva mai davvero affascinata. Lei voleva appartenere, sicuramente non voleva essere sua, non sapendo come esserlo. Le sembrava un pensiero quello di appartenersi. Un’invenzione.
In nessun modo voleva lasciarmi. Voleva stare in me, con me.
Più volte l’avevo sentita dire che era mia – così come io pensavo e volevo – e altre volte, senza parole – senza mentire cioè – aveva lasciato intendere che fosse me.
Era la cosa più profonda e più intima che avessi mai avuto. Mi ossessionava cercare di capire cosa significasse per me ‘averla’. Disporne liberamente? Includerla nel mio senso di ‘me’, quant’anche corporeo?
Vivevo male, tremendamente anzi. Era talmente mia che era ovunque in me. La sentivo nel respirare, persino nel modo in cui certe consonanti uscivano dalle labbra. Io la percepivo come una forma dentro di me. Una forma viva. Era sempre nel mio pensiero. Per questo mi ero rassegnato al fatto che fosse me, e che le preposizioni, come i pensieri, erano invenzioni.
******************************************************************************************************
Sono stato da una vecchia ieri pomeriggio. È stato un incontro progressivo. Prima c’era una barriera che avevo messo io e aveva messo lei. Io l’avevo messa per abitudine, e lei perché, come tutte le persone di buon senso, voleva captarmi prima di incontrarmi.
Le ho chiesto se poteva leggermi. E lei ha detto sì. Era fondamentale che non lo facesse per soldi, e ho sentito che era così, nonostante i soldi. Ha mosso le braccia attorno a me come se fossero vele. Pochi secondi. Ho sentito che ha sentito, non ho avuto paura.
Ha visto che c’era un buco dove non doveva esserci. Che mi mancava qualcosa di mio, che era normale che fosse mio.
Ho visto le sue sopracciglia incresparsi come di fronte ad un orrore. Non ci credeva quindi ha di nuovo veleggiato di fronte a me per sincerarsi di quel presentimento. Di morte.
Si è spaventata, più di quanto lo fossi io. Io già sapevo, già sentivo. Non ho più paura che gli altri sentano.
Si è affrettata a mettermi pietre sulla mano destra, cerotti minerali che potessero riportarmi ciò che non c’era più. La mia mano era aperta come un dolore. Accoglieva le pietre.
Cosa sono le pietre? parole.
******************************************************************************************************
Lo ho sognato, anche questa notte. Aveva, cioè ha, dei capelli bellissimi, che non mi escono dagli occhi. Non sono mai usciti, da quando li ho visti per la prima volta. Non ricordo altro del sogno, se ci fossero parole, cioè invenzioni, cioè bugie, tra noi due. Così raramente riusciva a stare in silenzio. Non mi ha dato niente – di suo – mai.
******************************************************************************************************
Ricordo con precisione quando ti ho data. Non me l’ha chiesta. Ti ho data io. Perché?
Vorrei mentire, vorrei dire – a me innanzitutto – che non ho potuto fare a meno di darti. Che lo desiderava, che ti desiderava. Addirittura che non sapeva di desiderarla, di desiderarti, ma che era così.
Eri tu. Tu volevi.
******************************************************************************************************
Ora che non sei più mia – ancora mi domando come sia possibile, cioè come sia reale – vorrei confessarmi. Vorrei dirti che cosa ha significato per me darti.
Per me dare significa perdere. Io non conosco cosa sia condividere. È una parola, è una invenzione. Se io do qualcosa di mio, io non lo ho più. E se lo do, l’ho dato. È successo, è già successo. Non ritornerà com’era. Mai più. Potrà tornare, potrà bussare alla mia porta supplicandomi con gli occhi pieni di latte di esserne di nuovo il tenutario, il possessore, il dolcissimo despota. Cosa vuol dire restituire? Si restituiscono gli oggetti, e niente è un oggetto. Ogni oggetto soggiace al tempo, tutto è tempo. Il tempo agisce inesorabile, alterando.
******************************************************************************************************
Spuntavano dallo scatolone all’intersezione tra Via Belpoggio e Via dell’Università le pantofole rosa che avevo comprato da Muji quattro anni fa. Avevo ammassato tutto ciò che in me era stato suo – suo senza che neanche lo sapesse. Eppure ventiquattro sacchi di immondizia nera e il comando dei carabinieri non erano bastati, ce n’era ancora. Ce n’è ancora così tanto.
Avevo furiosamente riempito lo scatolone, dentro c’erano cose che erano state (e quindi sarebbero eternamente state) essenzialmente sue – cioè cose che non avevo mai sentito mie, mai, impossibile – e cose mie che erano eternamente diventate sue senza che né io né lui lo volessimo. Però ricordo, ecco. Ricordo il giallo del cotone delle sue calze. La sottigliezza delle sue caviglie, i peli né ispidi né fragili, né troppi né pochi. La densità fredda delle ossa del tallone. La zigrinatura della pianta, la compostezza vittoriana delle unghie – ‘onge’ le chiamava – anche quando non le tagliava. Il suo alluce nella mia bocca come un dattero. Ricordo il giallo dentro al rosa delle pantofole – non avevo concesso, avevo concesso? insomma la stagione si era infreddolita e mai avrei voluto che i suoi piedi, cioè i miei piedi, patissero – lo stupore assoluto di veder questi due colori parlarsi, amarsi, giocare sul confine come due nemici amici. Non li avevo mai visti insieme.
Quando con gli occhi esterrefatti mi ha visto montare verso di lui sul marciapiede di Via Belpoggio come un bufalo impazzito, sapeva che le parole che ci saremmo scambiati sarebbero durate per sempre?
Guarda scioccato dentro lo scatolone aperto, vede le pantofole
Apre la bocca: “Ma queste sono tue”
La mia bocca è chiusa, le mie narici spalancate.
Le parole sono invenzioni.
Lo guardo con tutto di me. Spero che lui veda nei miei occhi la mia risposta.
******************************************************************************************************
Cosa vuol dire ‘nostro’? Per davvero, intendo.
Cos’è casa nostra? I nostri soldi?
Quando sento che al bambino si dice: “certo che è tuo, ma puoi prestarlo a Sebastiano Cosmo Nina Sofia così ci gioca un po’, e poi te lo ridà”, io entro nei muscoli delle falangi di quel bambino e mi contraggo e stringo e stringo stringo fortissimamente e non respiro e sento la perdita, la perdita completa e inesorabile, sento le lancette dell’orologio, le linee che si formano avide sulla fronte, quell’incubo nel dare che è perdere, interrompere la preservazione privata, devota, pura, della materia, materia che è sacra, materia che se è di me, è mia,
non
è
nostra.
se
è
nostra,
anche tu
sei
me.
******************************************************************************************************
ti ho data a lui perché
(volevi)
ho deciso
(non ha deciso)
che lui
era
me
mio
Lui
non era mio
ti ho data
per sempre
sei
per sempre
perduta
lui
nemmeno sa
di averti
di avermi
per sempre
sono
perduto
******************************************************************************************************
Ti prego:
torna
torna mi
torna me